Autore: wp_7644977
Whitaker
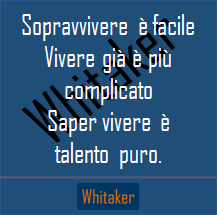
Sulle cose lascio correre, è il mio modo di fingermi asceta. Di solito. Poi se mi impunto, beh, è diverso: ci provo proprio gusto a fare il cagacazzi.
A cinque giorni da una disavventura dal meccanico, ci sono dovuto tornare per il tagliando. La volta prima, quella della disavventura, non gli ho cantato le classiche quattro, ho fatto proprio un miniconcerto live. E, uscendo, ho fatto pure gli occhi torvi, come nella migliore tradizione dei rocchettari maledetti.
Non sapevo che aspettarmi, quindi, ma sapevo che si sarebbero ricordati. Comunque, lascio la macchina e salgo sul taxi per andare in ufficio.
Quando torno a riprendermela, all’accettazione, corrono furtivi gli occhietti di Giada, riparando in quelli di Augusto, l’addetto alla riconsegna. Non riesco nemmeno a salutare e non capisco. In verità, mi agita un po’ la cosa, ma dissimulo, da stronzo consumato.
Qualche secondo e sento la basculante alzarsi, mi affaccio e vedo il muso cattivo e stupendo della mia macchina. Cesare, il titolare, scende molleggiando tanto è contento, come un bambino che ha vinto ai videogiochi, e non riesce a frenare le parole:
«Dotto’, l’ho provata personalmente e per farmi perdonare, l’ho fatta pure lavare!»
Effettivamente, pare illuminata, brilla che nemmeno nuova era così. Lo ringrazio pure io molleggiando e ridendo, sodale, manco me la stesse regalando l’auto.
E nel finale mi dà il pass vip che agguanto al volo: «La prossima volta si rivolga a me, Augusto è meno affidabile.»
Non gli dico che non avrebbe dovuto, che era tutto a posto, le solite smancerie, insomma. Non c’è niente da fare, il muso duro, le parole grosse, la faccia tosta – mia e sua – a volte pagano.
Però l’ho perdonato e apprezzato. Ha recuperato un torto senza ipocrisia e senza servilismo, con l’arte del saper vivere.
Whitaker
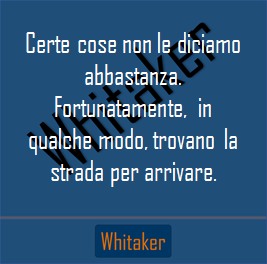
Zio Milvio è venuto a trovarmi in ufficio. Un’improvvisata. Ne fa, ma non spesso e io, anziché fare gli onori di casa, ho cominciato a lamentarmi di lavorare tanto, troppo, non avere tempo libero a sufficienza. E, intanto, ne stavo rubando un altro po’ a entrambi, invece di godermi il momento. Si alza, apre il mobile dove tengo le bottiglie e, con calma, si versa una generosa porzione di Lagavulin 16 anni, quello che sa un po’ di fumo, come dice lui. Poi, tra lo spazientito e il divertito, mi fa: “Diciamoci la verità: questa è come te la racconti. In realtà non sapresti starci nemmeno un mese, lontano dall’azienda.”
E comincia a ricordarmi di quanto mi gratifichi, diverta, appaghi, renda felice. Di come il lavoro sia ovunque nella mia vita, in ufficio e non.
Certo, capita la giornata no, in cui manderei – dice lui – affanculo il mondo, innocenti inclusi, ma questa è un’altra storia.
Lavorare, e fare questo nello specifico, pompa adrenalina, tiene vigile e svegli. Non è, probabilmente, nemmeno il legame emotivo con i collaboratori, l’azienda, i soci. Ci si può farne a meno, delle persone e delle cose, almeno così ci si convince.
È l’essere un ingranaggio di una delicata catena di montaggio a farmi stare bene, mi spiega. Sapere che senza di me, il sistema si fermi, si inceppi o anche solo rallenti: È magia e incantesimo.
Mi regala un potere, ma soprattutto una gioia, che lo stipendio e gli utili e i benefit non riescono a comprare. E poi c’è la fortuna di incontrare un sacco di gente. Individui capaci, illuminati, caparbi, ma anche incompetenti, quando non dei completi idioti. Brava gente e delinquenti. Truffatori e onesti padri di famiglia. Persone con una dignità solida da sorreggere palazzi e altri con la spina dorsale di formaggio spalmabile. Scaduto.
Da tutti si impara.
“E tu, zio Milvio non smettere di insegnarmi” – ma non l’ho detto, l’ho solo pensato. Non le diciamo mai abbastanza certe cose, però in qualche modo, trovano la strada per arrivare.
Con la porta aperta
Romance non stop
e-Book new price
Whitaker
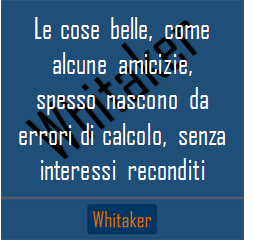
Mi vortica la stanza intorno e il letto sotto e non mi riesce di dormire. L’open bar ha dato buoni frutti, a quanto pare e, da professionista consumato del dopo sbornia, aspetto paziente svaniscano gli effetti. La camera e il letto non girano per davvero, in cuor mio lo so, però la mente non riesce a capacitarsene lo stesso. Mentre combatto con questi enigmi, sento lo scroscio della doccia. Ovviamente non do credito alla cosa, so di essere solo in camera. Poi però l’acqua diventa più insistente e sento pure un leggero sibilo, come un fischio, lieve, lontano. Devono servire alcol veramente potente, qua alle Maldive, penso, racimolando quel che resta di me. Una mano gigante mi raccoglie dal lenzuolo, come facendo la scarpetta dal piatto, quindi mi mette in piedi: non mi resta che andare a vedere. Il giallo fluo della pinna sul bordo della vasca mi attira subito, ma, di più, mi stupisce il tizio sotto la doccia che canticchia con gli occhi chiusi, la cui presenza conferma che non sono pazzo o ancora ubriaco.
Abbiamo l’overwater attiguo e, salendo dalla laguna dopo aver rincorso una murena, il “genio” ha sbagliato scaletta entrando nel mio bagno anziché nel suo. Mica si è posto il problema che in bagno ci fossero un boxer non suo, lo shampoo che non si è portato da casa e il beauty che hanno regalato a me e non a lui? Ho aspettato che finisse la doccia, con le mani in tasca e un ghigno in faccia. Siamo diventati amici, non potevamo non esserlo. Beviamo insieme, da allora a C. e ancora ne ridiamo.
#Festadellamamma #Regalaunlibro
Whitaker
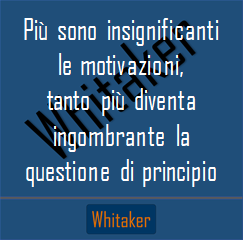
Non mi piace l’open-space, ma ne abbiamo alcuni in azienda. Io ho un ufficio blindato e tutto mio, nell’ultima stanza dell’ultimo corridoio, all’ultimo piano. Ci devi venire apposta, insomma, fosse anche soltanto per sbirciare. Per questo, i più mi dicono classista, antipatico, snob. Io semplicemente la chiamo “privacy”, ma perché dire in pubblico “non mi piace che ci si intrometta nei cazzi miei”, potrebbe sembrare brutto. Dimenticavo: pure stronzo mi dicono, ma su questo hanno ragione, probabilmente. Comunque, nel mio posto nascosto, sono stato costretto a ricevere due collaboratori, due colonne della E. Appena entrati realizzo che avrei dovuto attrezzarmi con gong e ring, invece di caffè e dolcetti e temo pure di beccarmi uno schiaffo se mi intrometto.
Luca pretende che Alfonso sia licenziato, Alfonso vuole che Luca sia spostato altrove, in modo da non averci più a che fare e vederlo, finanche. Nemmeno capisco l’accaduto e chi abbia cominciato, so solo che devo farli smettere, senza avere una soluzione, però. Non dico che prima dividessero lo sgabello al bar, ma avevano un rapporto solare, cordiale e di reciproco rispetto.
Si sa, più sono insignificanti le motivazioni e più diventa ingombrante la questione di principio e quasi impossibile fare poi un passo indietro. Io, per mio innegabile interesse lavorativo, non posso e voglio scontentare uno dei due, dando ragione a chi effettivamente ce l’abbia e devo districarmi sul filo. Vogliono e pretendono che li separi. Per sempre.
E su queste loro frasi scatta il lampo di genio: «Signori, dobbiamo convivere. Pure con le mogli si litiga e non è che alla prima baruffa si divorzia» sbotto tra il disperato, il rassegnato e l’incazzato.
Manco avessi pronunciato un sortilegio (sarà stata la parola “moglie”), i due fanno la pace e si stringono la mano, dandomi ragione all’unisono.
Ancora mi chiedo cosa abbia detto di così fondamentale: le mie parole erano spinte più da un bisogno esasperato che non da un pensiero filosofico o una soluzione pratica.
E niente, sono questi i momenti in cui mi compiaccio: risolvi la guerra tra Stati Uniti e Corea, quando volevi solo pranzare in orario.










